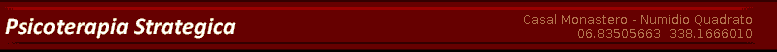|
La psicoterapia breve strategica si propone di aiutare il paziente a
risolvere, efficacemente e nel minor tempo possibile, le
problematiche per cui si presenta in terapia.
Per questo motivo è fondamentale che la
coppia paziente/terapeuta espliciti, nel contratto terapeutico, gli obiettivi terapeutici
che realisticamente intende perseguire. L'accordo operativo fra
cliente e professionista così concretizzato rappresenta il risultato finale del complesso processo di analisi della domanda che
necessariamente precede la realizzazione di una psicoterapia.
Essendo imperniata su un'epistemologia
costruttivistica, la psicoterapia breve strategica considera la
“realtà” il prodotto di una costruzione personale
(all'interno ovviamente della circolarità delle
interazioni del singolo con i contesti di riferimento). Essendo
comunque la costruzione personale dell’individuo a determinarne
comportamenti, pensieri ed emozioni, la pratica clinica
dell’approccio strategico mira a sostituire una “realtà”
sgradita e\o limitante, ossia problematica e disfunzionale, con una
più soddisfacente. Ciò avviene comunque nella
consapevolezza che la nuova “realtà” non può
essere ritenuta, in senso stretto, più vera di quella
precedente. Nelle parole di Watzlawick (1997:16), “la
psicoterapia si occupa della ristrutturazione della visione del mondo
del paziente”.
Da questo punto di vista si può quindi
sostenere che la psicoterapia strategica fondamentalmente si pone
come obiettivo generale una modificazione della prospettiva
cognitiva del paziente, intervenendo quindi sulla sua percezione
di sé stesso, degli altri e del mondo. L’implicazione di fondo di questo
approccio è pertanto che modificando le opinioni della persona
sia possibile determinare cambiamenti a livello non solo cognitivo,
ma anche comportamentale ed emotivo.
Le modalità di intervento nella fase di
individuazione e modifica delle prospettive disfunzionali del
paziente sono molteplici e differenziate. A grandi linee è
possibile però individuare con chiarezza almeno due
orientamenti che, tra l’altro, non sono auto-escludentisi ma
possono bensì essere integrati in fasi distinte del processo
terapeutico: quello centrato sul problema (Watzlawick, 1997) e quello
centrato sulla soluzione (de Shazer et al., 1997).
Nell'analisi della costruzione del problema,
particolare attenzione viene rivolta al sistema percettivo-reattivo
del paziente: le specifiche modalità di attribuzione di senso
agli eventi e le relative strategie comportamentali messe
abitualmente in atto dalle persone costituiscono una solida
impalcatura a mantenimento del disagio psichico. In altri termini, l’approccio centrato
sul problema cerca di individuare a ritroso la struttura cognitiva
che è alla base del disagio: le opinioni e le credenze
dell’individuo relativamente a se stesso, agli altri ed al
mondo stesso. L’ipotesi di fondo di questa prospettiva è
che, una volta individuate le prospettive cognitive disfunzionali che
inevitabilmente sono alla base del disagio psichico, sia possibile,
con interventi strategicamente orientati, sollecitarne una
ristrutturazione in senso maggiormente adattivo e funzionale
(Watzlawick, 1997).
Negli approcci centrati sulla soluzione,
invece, la persona viene considerata bloccata nel proprio percorso di
crescita: a causa di opinioni e convinzioni disfunzionali si trova ad
essere impossibilitata a procedere verso la soluzione delle proprie
difficoltà. Nell’approccio di de Shazer et al. (1997),
il paziente viene stimolato al cambiamento attraverso interventi che
lo orientano a rafforzare le opinioni e credenze circa se stesso, gli
altri ed il mondo che caratterizzano non la sua visione attuale della
realtà, ma la sua visione della realtà conseguente alla
soluzione del problema. In questa maniera, pur se da una prospettiva
differente, si ottiene comunque in ogni caso una ristrutturazione
della realtà attuale ed uno sblocco dei processi disfunzionali
(cognitivi, comportamentali e/o emotivi) causati da una costruzione
maladattiva del presente.
Da un punto di vista più
specificatamente metodologico, ad ogni modo, non vengono individuati
limiti predefiniti alle strategie da impiegare per sostenere la
ristrutturazione delle opinioni e credenze alla base del disagio.
Infatti, l’impiego dell’ipnosi non direttiva, delle
prescrizioni paradossali, di tecniche emotivo-espressive importate da
altri approccio (quali per esempio la tecnica della sedia vuota della
Gestalt), etc. sono solo alcuni degli strumenti che il terapeuta
strategico può utilizzare al fine di conseguire la
ristrutturazione delle idee ed atteggiamenti alla base del disagio.
In sintesi, il terapeuta interviene,
attivamente e consapevolmente, con la finalità di perturbare,
in modo strategico, il sistema percettivo-reattivo del paziente
attraverso richieste paradossali, tecniche di sorpresa e/o di
confusione, uso dell'ironia, tecniche ipnotiche ed altre strategie
opportunamente impiegate, sollecitando definizioni della situazione
e/o soluzioni comportamentali alternative rispetto a quelle in uso,
rivelatesi non soddisfacenti.
|